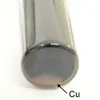Mario
2013-02-11 20:28
I composti cromosi, quelli in cui il cromo manifesta il numero di ossidazione +2, sono molto instabili in quanto facilmemente ossidabili dall'ossigeno atmosferico. Il potenziale redox della coppia (-0,41V) è così basso da rendere possibile la riduzione dello ione H+ anche da soluzioni poco acide. Fortunatamente la reazione è piuttosto lenta, altrimenti sarebbe impossibile ottenerli in soluzione aquosa.
Nonostante queste difficoltà, si possono tuttavia preparare soluzioni acquose contenenti Cr++ e perfino un suo sale stabile all'aria con mezzi e reagenti assolutamente alla portata di tutti.
Vediamo come.
Servono i seguenti reagenti:
- potassio bicromato
- HCl 35%
- acetato di sodio triidrato
- zinco in pezzi (vanno bene quelli con peso di circa 0,5 g)
- olio di vaselina
- provetta di vetro
- imbutino di vetro
Si introducono nella provetta 0,5 g di bicromato e 2 mL di HCl e dopo accurata miscelazione, si posiziona l'imbutino che avrà la funzione di evitare schizzi e limitare, almeno in parte, le perdite di HCl.
Si porta a moderata ebollizione per un paio d'ore. Il contenuto inizia a reagire passando da arancione a verdastro:
Si riprende con 1 mL di acido e si continua l'ebollizione per ancora 1 ora.
Al termine si otterrà una soluzione verde scura contenente il cromo trivalente.
In pratica è avvenuta una reazione redox nella quale il bicromato ha ossidato lo ione cloruro a cloro e contemporaneamente si è ridotto a ione trivalente.
K2Cr2O7 + 14HCl ==> 2CrCl3 + 2KCl + 3Cl2 + 7H2O
In realtà la reazione appena vista è una semplificazione. Nella realtà il cromo trivalente è sotto forma di un complesso di probabile formula [CrCl2(H2O)4]Cl.2H2O.
Il contenuto viene quindi diluito con poca acqua, fatto bollire per eliminare l'eccesso di HCl e diluito infine a 30 mL.
Una porzione di 10 mL è trasferita in una piccola provetta, si aggiunge un pezzo di zinco, si stratifica un poco di olio di vaselina per impedire il contatto con l'aria e si lascia reagire a temperatura ambiente per un giorno intero. Si sviluppa idrogeno e nel contempo avviene la riduzione a sale cromoso di colore azzurro.
Anche in questo caso il cromo è presente come complesso, nel quale è coordinato con 6 molecole d'acqua: [Cr(H2O)6]++
Ecco il suo aspetto. Per confronto lo si è fotografato con la soluzione di partenza.
E' interessante notare come il colore, benchè diverso, si sia notevolmente attenuato di intensità. Gli spettri di assorbanza (vedi allegato) sono molto particolari, specie quello del sale cromoso che mostra una larga banda di assorbimento nell'infrarosso.
Proseguiamo.
La cosa migliore è riunire i 20 ml di soluzione del Cr+++ non utilizzata e concentrarli a circa 8-10 mL. Dopo di che effettuiamo la solita riduzione a Cr++. A parte prepariamo una soluzione concentrata di acetato di sodio (alcuni ml). Questa soluzione la inietteremo mediante una pipetta direttamente nella soluzione del sale cromoso al di sotto dello strato di vaselina. Si forma subito un voluminoso precipitato color rosso mattone di acetato cromoso.
Dopo decantazione si noterà che la fase acquosa è debolmente colorata in rosso-violetto dovuto alla piccola quantità del sale cromoso che rimane in soluzione.
Senza indugio possiamo filtrarlo su Buchner lavandolo rapidamente con etanolo 95% a cui segue una essicazione con aria tiepida.
Il sale ottenuto, di formula Cr2(O2CCH3)4(H2O)2, è stabile all'aria secca.
Ne ho sintetizzato poche decine di mg, giusto per mostrarvi il suo aspetto:
saluti
Mario
I seguenti utenti ringraziano Mario per questo messaggio: Dott.MorenoZolghetti, Rusty, Guns n'Roses, Max Fritz, al-ham-bic, quimico, Christian, Daedalus, marco the chemistry, rock.angel, fosgene, Davide93, ale93, luigi_67, Igor





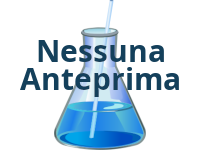
 Acc, solo a leggere Cr2+ mi dispero, al ricordo di quante volte ho tentato di sintetizzare del CrCl2*4H2O (da acetato cromoso sciolto in HCl conc tentando poi di far precipitare il sale con HCl gassoso secco prendendo tutte le precauzioni per non far entrare aria....) e tutte le volte ho fallito (rovinando tra l'altro la roba in Al e mettendo a dura prova i filtri della mia maschera).
....Magari qualcuno più bravo di me riuscirà dove io non ce l'ho fatta...(la verità è che muoio dalla voglia di vedere un sale cromoso (azzurro) idrato)
Marco, eventualmente usa un sottile strato di n-esano...
Acc, solo a leggere Cr2+ mi dispero, al ricordo di quante volte ho tentato di sintetizzare del CrCl2*4H2O (da acetato cromoso sciolto in HCl conc tentando poi di far precipitare il sale con HCl gassoso secco prendendo tutte le precauzioni per non far entrare aria....) e tutte le volte ho fallito (rovinando tra l'altro la roba in Al e mettendo a dura prova i filtri della mia maschera).
....Magari qualcuno più bravo di me riuscirà dove io non ce l'ho fatta...(la verità è che muoio dalla voglia di vedere un sale cromoso (azzurro) idrato)
Marco, eventualmente usa un sottile strato di n-esano...